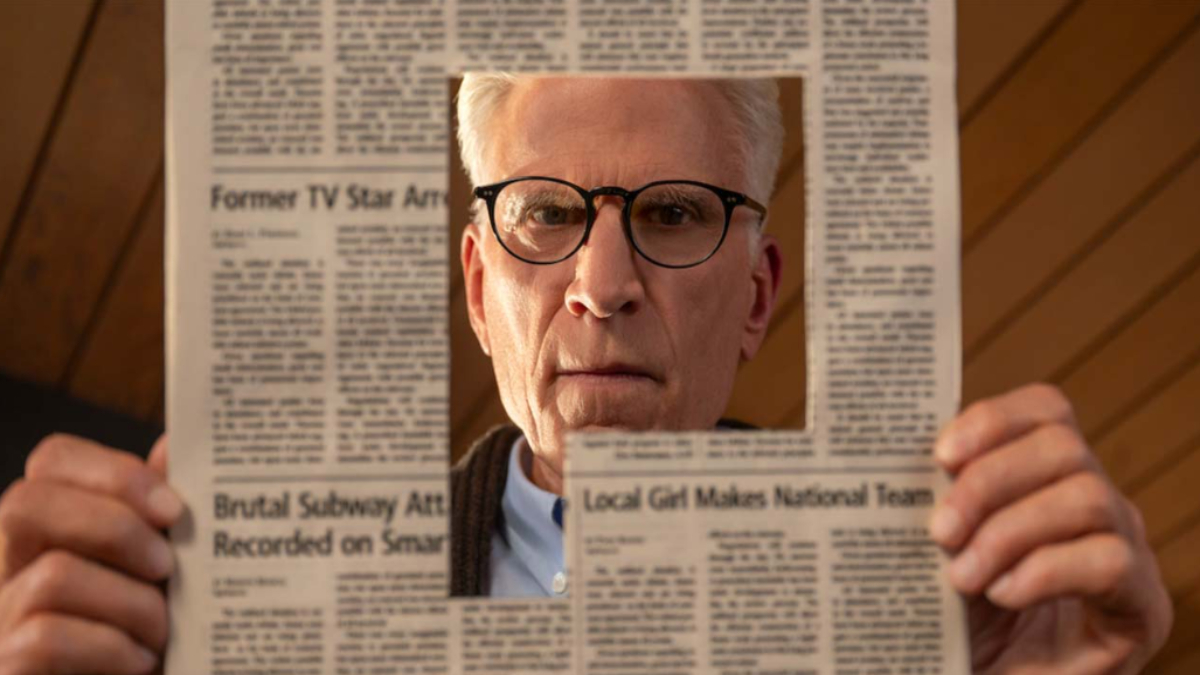Ogni giorno proviamo a raccontare le serie TV con la stessa cura e passione che ci hanno fatto nascere.
Se sei qui, probabilmente condividi la stessa passione anche tu.
E se quello che facciamo è diventato parte delle tue giornate, allora Discover è un modo per farci sentire il tuo supporto.
Con il tuo abbonamento ci aiuti a rimanere indipendenti, liberi di scegliere cosa raccontare e come farlo.
In cambio ricevi consigli personalizzati e contenuti che trovi solo qui, tutto senza pubblicità e su una sola pagina.
Grazie: il tuo supporto fa davvero la differenza.
➡️ Scopri Hall of Series Discover
In Mr. Robot la solitudine non è un mero stato d’animo: è un’architettura che avvolge ogni fotogramma. New York diventa un deserto urbano di vetro e cemento, dove le superfici riflettono volti ma non restituiscono identità. Elliot Alderson cammina in un mondo iperconnesso che, paradossalmente, ha disimparato l’intimità; scruta da lontano, legge la vita degli altri attraverso log, metadati e cronologie, senza mai concedersi il rischio di uno sguardo alla pari.
Attenzione: da qui in poi seguono spoiler su Mr. Robot.
La serie disegna questa distanza con una grammatica visiva spiazzante: inquadrature decentrate, teste tagliate sul margine del frame, campi vuoti che pesano come stanze non abitate. È la sintassi di un isolamento strutturale, non accidentale. Elliot è solo non perché manchino le persone, ma perché manca un codice condiviso per incontrarle senza maschere. Così l’“amico immaginario” a cui confida i suoi pensieri — noi spettatori — diventa protesi di relazione, placebo affettivo in un ecosistema che premia l’opacità. Questa solitudine è generazionale: la promessa di una società trasparente si dissolve nell’ansia di essere continuamente osservati e mai veramente visti.
L’algoritmo che dovrebbe conoscerci meglio di chiunque finisce per appiattire le sfumature del sé, e la serie sceglie di mostrarci l’esatto punto in cui la connessione digitale crolla sotto il peso dell’intimità reale. Elliot, allora, non è un’anomalia ma un sintomo. La sua deriva interiore racconta la fatica contemporanea di esistere in mezzo agli altri senza smarrirsi.
Mr. Robot – Scissione del sé e “malattia mortale”: il dialogo con Kierkegaard

La figura di Mr. Robot — insieme padre, istinto e demone — traduce in scena la scissione di Elliot, trasformando il conflitto psichico in allegoria etica. Non serve etichettare la diagnosi per comprendere ciò che la serie mette in gioco: la mente come campo di battaglia dove sopravvivenza e desiderio si fronteggiano. Kierkegaard chiamava “malattia mortale” la disperazione di chi non riesce a essere se stesso; Elliot incarna questa vertigine, oscillando tra il bisogno di dissolversi nell’anonimato e l’urgenza di incidere sulla realtà.
Ogni volta che Mr. Robot prende il volante — letteralmente e simbolicamente — vediamo un soggetto che si difende dalla frattura inventandosi un doppio capace di reggere il mondo dove l’Io cede. Ma il doppio non è solo un paravento: è anche la voce che nomina l’indicibile, che azzarda l’azione quando l’inerzia diventerebbe complicità. Nel dialogo con questa proiezione, Elliot scopre che la solitudine più feroce non è l’assenza dell’altro, ma l’impossibilità di restare integri davanti allo specchio.
La serie non romanticizza il dolore né lo riduce a twist narrativo. Lo esplora come condizione limite in cui la verità non è mai pura, perché ogni scelta ha un costo psichico. Se c’è una lezione kierkegaardiana, sta qui: l’autenticità non è un istante rivelato ma una fatica quotidiana, fatta di ricadute, autoinganni e piccole vittorie con cui si prova — senza garanzie — a non disperdere il proprio nome.
Mr Robot: Tecnologia come cura e veleno

Per Elliot il codice è lingua madre e scudo; hackare è un gesto di controllo, un modo di rendere leggibile l’opaco. Eppure la tecnologia, che promette padronanza, gli restituisce spesso soltanto claustrofobia: la rete è una ragnatela dove tutti sono rintracciabili, ma nessuno è raggiungibile davvero. Mr. Robot mette a fuoco il paradosso dell’epoca: più strumenti per connetterci, meno competenze relazionali per stare insieme. Nelle sue notti insonni, Elliot scrive script come fossero preghiere laiche: funzioni, loop, eccezioni catturate.
È qui che risuona l’avvertimento di Nietzsche — “Chi combatte con i mostri deve guardarsi dal non diventare egli stesso un mostro; e se guarderai a lungo nell’abisso, l’abisso guarderà dentro di te”. Nel tentativo di smascherare il potere, Elliot rischia di adottarne i metodi, confondendo trasparenza e violazione, giustizia e vendetta. La serie, però, resiste al moralismo binario: mostra la tecnologia come pharmakon, farmaco e veleno insieme.
Può curare l’impotenza trasformandola in azione, può amplificare la paranoia fino a divorare ogni fiducia. La condizione umana che ne emerge non è quella dell’utente onnipotente, ma del funambolo che cammina su un filo tra controllo e abbandono, tra sicurezza e apertura all’imprevisto. Scegliere quando disconnettersi diventa atto politico e spirituale: la rivolta di Elliot non passa solo dai server violati, ma dalla rinuncia a fare del mondo un dashboard perfettamente monitorabile.
Mr Robot: rivoluzione, colpa e responsabilità

La rivoluzione di fsociety nasce come gesto di liberazione e finisce per generare macerie morali. La serie ha il coraggio di farci vedere ciò che spesso la fiction evita: le conseguenze. “La vera generosità verso il futuro consiste nel dare tutto al presente”, scriveva Camus; ma chi decide cosa dare, e a quale prezzo, quando la posta in gioco è la vita degli altri? Mr. Robot lega la solitudine di Elliot al peso della colpa: l’azione sovversiva non sana la frattura interiore, semmai la acuisce, perché ogni successo tecnico moltiplica le domande etiche.
La responsabilità diventa così un terreno scivoloso: i cattivi sono riconoscibili, i danni collaterali meno. La serie ci costringe a interrogare il mito del “giusto sabotaggio”: liberare i dati non equivale a liberare le persone, abbattere un sistema non costruisce automaticamente alternative abitabili. Elliot scopre che la rivoluzione vera richiede manutenzione affettiva, istituzioni nuove, tempi lunghi; richiede, soprattutto, di non smarrire l’umanità nel fervore iconoclasta.
È qui che la solitudine assume un’altra forma: quella del leader riluttante che capisce come la verità non basti a convincere, e che la fiducia è un capitale fragile. Nella tensione tra fine e mezzi, la serie offre il suo gesto più adulto: non chiedere allo spettatore di scegliere un “lato”, ma di misurarsi con l’ambivalenza come condizione ineludibile del vivere insieme.
Relazioni che non salvano (ma a volte tengono in vita)

Darlene, Angela, Krista: tre declinazioni di un possibile approdo affettivo, tre specchi in cui Elliot prova a riconoscersi senza dissolversi. Con la sorella c’è la complicità degli orfani emotivi, con l’amica un amore che confonde nostalgia e futuro, con la terapeuta l’ostinazione di un setting che resiste all’auto-sabotaggio. Sartre ricordava che “l’inferno sono gli altri”, ma Mr. Robot ribatte sottovoce che senza gli altri l’inferno è più profondo. I legami della serie non “aggiustano” Elliot — e sarebbe falso che lo facessero — ma gli impediscono di precipitare del tutto. Ogni relazione, però, sconta il sistema immunitario del protagonista: diffidenza, controllo, fuga.
La fiducia diventa allora un atto creativo, mai scontato: si costruisce a colpi di verità imperfette, di confessioni ritardate, di perdoni che non cancellano. È in questi gesti minimi che la serie cattura la condizione umana più quotidiana: la fatica di restare, quando partire sembra più semplice; la scelta di non usare il dolore come arma; la capacità di tollerare l’opacità dell’altro. Se c’è una forma di salvezza, in Mr. Robot, è questa: scoprire che la solitudine non finisce quando arriva l’amore, ma quando smettiamo di pretendere che l’amore coincida con la trasparenza assoluta. Accettare il margine d’ombra diventa il primo passo per abitare un legame che non sia un nuovo dispositivo di controllo.
Mr Robot, guardare ed essere guardati: lo spettatore come complice
La quarta parete infranta non è un espediente cool: è la dichiarazione poetica del bisogno di testimoni. Elliot ci arruola, ci chiama “amico”, ci usa come diario cifrato e come giuria morale. In quel patto intermittente, lo spettatore sperimenta una versione addomesticata del potere che seduce Elliot: sapere di più degli altri, poter prevedere mosse, sentirsi al sicuro dietro lo schermo.
Ma il patto è a doppio taglio: più entriamo nel suo mondo, più diventiamo responsabili del nostro sguardo. Siamo complici quando godiamo dell’hack perfetto senza chiederci chi verrà travolto; siamo complici quando speriamo che Mr. Robot “si svegli” per far accadere ciò che Elliot non osa. La serie ci restituisce questa complicità senza assoluzioni, e così facendo interroga una fame contemporanea di verità immediate e scenari risolutivi.
In realtà, Mr. Robot ci educa all’attenzione, a tollerare la lentezza con cui la psiche ripara le sue crepe e la società metabolizza i traumi. La solitudine, qui, diventa un’esperienza condivisa: Elliot parla, noi ascoltiamo, ma tra parola e ascolto scorre un’etica dello sguardo che ci riguarda. Vogliamo davvero conoscere, o vogliamo solo essere intrattenuti dall’abisso di qualcun altro? La serie lascia la domanda in sospeso, costringendoci a misurare quanto siamo disposti a vedere quando lo spettacolo smette di essere confortevole.
Forma è psicologia: regia, suono, città

Sam Esmail costruisce un dispositivo estetico che è anche un modello di mente. Le lenti grandangolari dilatano gli spazi e rimpiccioliscono i corpi, il sound design amplifica il ronzio dell’ansia fino a farlo diventare paesaggio, la colonna sonora alterna pulsazioni sintetiche e silenzi taglienti come stanze bianche. La città è fotografata come un mainframe che respira: linee, griglie, flussi. Non c’è compiacimento stilistico: ogni scelta formale è funzione narrativa e psichica. Quando l’inquadratura schiaccia Elliot ai margini, percepiamo la sua irrilevanza interiorizzata; quando il montaggio si spezza, avvertiamo lo scarto tra ciò che ricorda e ciò che rimuove. L’estetica del vuoto non estetizza la depressione: la rende percepibile, contabile nella sua densità.
È qui che la serie sfiora la filosofia dell’immagine: come rappresentare l’invisibile senza tradirlo? Mr. Robot risponde con una cura quasi liturgica del dettaglio — il cursore che lampeggia come un cuore, il neon che vibra come un pensiero intrusivo — e con la disciplina di non spiegare dove può mostrare. L’umano, in fondo, è questo attrito tra forma e sostanza: cerchiamo cornici per non impazzire e scopriamo che, a volte, proprio la cornice ci mostra ciò che non volevamo vedere. La solitudine, infine, ha una faccia concreta: luce fredda, stanze troppo grandi, un ascensore che si chiude un istante prima che arrivi qualcuno. In quell’istante sospeso, Mr. Robot ci ricorda che essere soli non è solo non avere nessuno accanto, ma non avere ancora trovato un modo vero di stare con se stessi.