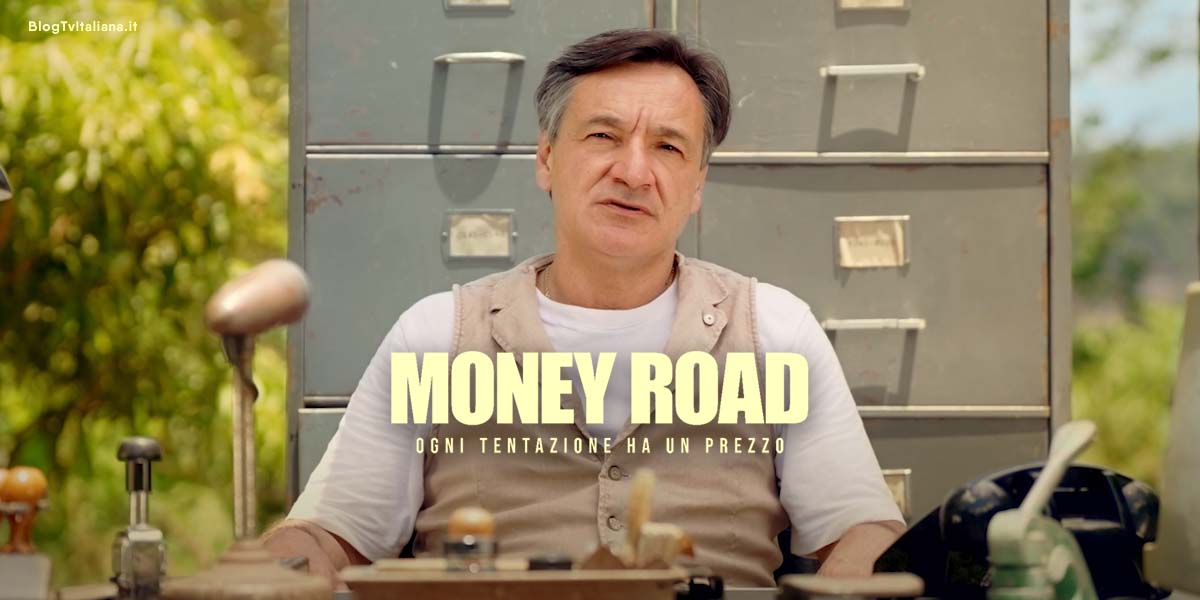Ogni giorno proviamo a raccontare le serie TV con la stessa cura e passione che ci hanno fatto nascere.
Se sei qui, probabilmente condividi la stessa passione anche tu.
E se quello che facciamo è diventato parte delle tue giornate, allora Discover è un modo per farci sentire il tuo supporto.
Con il tuo abbonamento ci aiuti a rimanere indipendenti, liberi di scegliere cosa raccontare e come farlo.
In cambio ricevi consigli personalizzati e contenuti che trovi solo qui, tutto senza pubblicità e su una sola pagina.
Grazie: il tuo supporto fa davvero la differenza.
➡️ Scopri Hall of Series Discover
È arrivata un po’ in sordina, e per certi versi c’è da sorprendersi. The Traitors, d’altronde, è un format che spopola da anni in mercati internazionali molto rilevanti, ed era preventivabile un successo notevole anche per la versione italiana. Stiamo parlando di un reality game che ha trionfato agli Emmy statunitensi e ai BAFTA britannici, certificando l’ottima riuscita di un format che si propone di rinnovare un genere che aveva faticato negli anni precedenti. L’arrivo in Italia attraverso Prime Video, allora, meritava più attenzione di quanta ne avesse ricevuta nelle settimane che avevano preceduto la messa in onda: il pubblico, in ogni caso, si è fatto sedurre dal passaparola dei primissimi giorni e ha dato fiducia a un prodotto molto interessante. Un prodotto capace di segnare, per certi versi, uno spartiacque nella storia del genere in Italia.
Un successo importante, non isolato. Il 2025 televisivo, infatti, ha regalato al pubblico italiano un altro fenomeno dei reality game di grande rilievo, ma con molte più incognite alla vigilia di quante ne abbia affrontate The Traitors. Money Road aveva stupito tutti nei mesi estivi, dando vita a un esperimento sociale intrigante che non si è fermato sulla carta (come spesso accade). Anche in questo caso parliamo di un format internazionale importato, ma l’affermazione in Italia era più imprevedibile.
Non una scommessa al buio, bensì una mossa audace di Sky. In una fase storica in cui ci si poggia costantemente sulle certezze del passato e la nostalgia rischia di tarpare le ali della creatività, il suo avvento, al pari di quello di The Traitors, sembra segnare l’inizio di una nuova fase per i reality game in Italia. Una fase che rigenera il genere con nuovi presupposti, senza accantonare la sua lunga e fortunata tradizione ultraventennale. E allora…
… Da Money Road a The Traitors: l’anno della rinascita dei reality game

Partiamo da un presupposto, onde evitare fraintendimenti: associare le dinamiche di The Traitors o Money Road a quelle dei reality show più iconici del panorama italiano, il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi, rischia di essere improprio da diversi punti di vista. Sono tipologie di prodotto molto diverse, per certi versi destinati anche a target differenti.
Come sempre accade nelle logiche del racconto televisivo, tuttavia, le evoluzioni generazionali passano sempre attraverso rinnovamenti graduali e allo sviluppo di forme ibridate. Si passa attraverso degli anelli di congiunzione, in sostanza. Immaginate, allora, The Traitors e Money Road come figli dell’esperienza dei reality tradizionali, ma anche di game show come Pechino Express (già) o LOL. Può sorprendere l’unione in un solo percorso di prodotti così diversi, ma è importante per lo sviluppo di questa analisi.
Il pubblico globale, tuttavia, tende a non soffermarsi granché su etichette del genere, più rilevanti per gli addetti ai lavori: l’etichetta, in questi due casi, è comunque quella dei reality. L’espressione reality game, allora, rende bene l’idea: il loro successo nasce dalle “ceneri” dei reality storici, ma anche dai linguaggi di game show che contengono nel loro format elementi evidenti della tradizione reality.
Per questo parliamo di una vera e propria resurrezione. L’etichetta è diventata ingombrante nel tempo, e spesso è associata aprioristicamente a prodotti con target ben specifici.
Ogni reality, però, ha storia a sé. Nel momento in cui si riconoscono elementi di reale novità e un potenziale appeal che va oltre le catalogazioni classiche, il pubblico generalista dal palato più o meno fine è sempre pronto a dare un’opportunità. Da qui l’intuizione vincente di Prime Video e di Sky: hanno scommesso su un genere che ha ancora molto da dare, e l’hanno fatto con un’impronta innovativa che ha attirato l’attenzione di una platea trasversale, spesso e volentieri distante – se non addirittura insofferente – nei confronti dei reality.
Detto questo: due indizi non fanno una prova, ma The Traitors e Money Road, seppure con presupposti molto diversi, sono figli di percorsi assimilabili che stanno dando un nuovo slancio all’universo narrativo dei reality. Oltretutto, potremmo evocare anche il famigerato terzo caso: Squid Game – The Challenge è tornato di recente su Netflix con la seconda stagione, e contiene anch’esso degli spunti che sarebbero utili per questa breve analisi. Fermiamoci però ai primi due: Squid Game è un prodotto internazionale, mentre qui parliamo di adattamenti italiani.
A questo punto, arriviamo alla domanda delle domande: perché The Traitors e Money Road stanno funzionando tanto bene?
Presentiamoli, intanto. The Traitors mette insieme un gruppo di persone e le chiude in un castello per alcuni giorni, con una dinamica essenziale: il gruppo deve cooperare per concludere delle missioni e arricchire così il montepremi che dovrebbe dividersi equamente tra i singoli giocatori. Con un ma grande come una casa: la produzione decide di nominare dei “traditori” che ordiranno dei complotti per eliminare i cosiddetti “leali”, col fine di arrivare alla fine senza essere scoperti e tenere per sé la cifra guadagnata. Ogni giornata è così scandita da due momenti, tra un gioco e l’altro: un momento in cui il gruppo elimina una persona con l’obiettivo di far fuori i traditori, mentre i traditori hanno a disposizione un’eliminazione notturna per scremare il gruppo dei rivali.
La prima edizione della versione italiana, composta da sei puntate da un’ora circa, è condotta da Alessia Marcuzzi e presenta un variegato cast di vip. Ha dalla sua una location suggestiva, elementi visivi dalla forte riconoscibilità (quanto servono, oggi) e un ritmo forsennato, ben assecondato da montaggi serrati che impacchettano il prodotto con grande efficacia. In un tempo in cui la soglia d’attenzione del pubblico è sempre più bassa, è fondamentale.
Non sono elementi da sottovalutare. Se da un lato The Traitors si presta perfettamente allo sviluppo di contenuti per i social coi momenti più intensi e le reazioni più rilevanti, dall’altro è un reality game dalla forte imprevedibilità.
Un’imprevedibilità che nasce da regole familiari al grande pubblico. I giochi da tavolo, d’altronde, non tramontano mai, la pandemia ha offerto a essi una nuova fase di popolarità e non è errato associare le dinamiche di The Traitors a quelle di “Mafia”, “Lupi e cittadini”, “Licantropi” o il celebre “Lupus in fabula”.
La prima stagione italiana funziona bene così com’è, e la viralità delle ultime settimane lo testimonia. Tuttavia, sarebbe interessante vedere in futuro una versione con un numero maggiore di puntate e un cast composto da nip: l’impressione è che sarebbero elementi utili per assecondare meglio il suo racconto, senza privarlo del dinamismo vorticoso che lo caratterizza.
Estetica, riconoscibilità, viralità potenziale sui social, familiarità con le regole e uno storytelling che può andare nelle direzioni più disparate in ogni momento: la formula di The Traitors è semplice, ma non per questo meno raffinata.

Altrettanto possiamo sostenere per Money Road. La versione italiana è condotta da Fabio Caressa ed è composta da sei puntate da novanta minuti circa. Il cast, in questo caso, è di persone comuni, ed è un presupposto fondamentale: come sottolinea più volte l’host, Money Road è un vero e proprio esperimento sociale. Di conseguenza, il casting si è orientato sulla scelta di personalità che ricostruiscono bene gli spaccati più diversi della nostra società. C’è un’Italia intera racchiusa in ciascuno dei personaggi coinvolti: questo ha dato il là all’ottima riuscita di un format anch’esso articolato, ma essenziale nelle regole di base.
Ovvero: il gruppo di persone deve portare avanti un percorso di trekking nella giungla malese, dalla durata di una settimana. Le condizioni sono estreme: le altissime temperature, l’umidità soffocante e il percorso irto di difficoltà mettono a durissima prova il gruppo. L’obiettivo è arrivare al traguardo, ma non è per niente semplice: oltre alle difficoltà del trekking in sé, capace di provare anche lo sportivo più esperto, il gruppo non può nutrirsi d’altro che di riso e acqua, senza avere a disposizione i bagni né alcun tipo di agio, tende e letti inclusi. Hanno un ricco montepremi a disposizione e non devono fare altro che arrivare alla fine per spartirselo equamente, ma… c’è il ma grande come una casa anche in questo caso.
Il gruppo, infatti, incontrerà sulla strada delle tentazioni. Tentazioni costosissime, a dir poco.
Un caffè per colazione? Cento euro, quando va bene. Un letto per dormire, magari in un lussuosissimo resort nel bel mezzo della giungla malese? Le cifre diventano altissime, assurde per i nostri standard ma non per chi campa per una settimana in quelle condizioni ed è disposto a tutto anche solo per mettere le mani su alcune scatolette di tonno. Tutto è possibile, in Money Road. E chiunque può decidere in ogni momento di cedere alle tentazioni e regalarsi un momento speciale. Però… ci vanno di mezzo tutti quanti.
Ogni tentazione ha un prezzo che pesa sul montepremi globale. Il gruppo deve accordarsi di volta in volta per decidere come possa essere corretto spendere o meno il budget a disposizione.
Spesso e volentieri, non deve nemmeno accordarsi: in gran parte dei casi, le persone possono avere accesso alle tentazioni indipendentemente da quello che pensano gli altri. Gli altri, talvolta, non ne vengono manco a conoscenza.
Non spingiamoci oltre: le variabili del gioco sono ancora più complesse e stratificate di così, ma non intendiamo rovinarvi la sorpresa. Per non parlare del finale: non sarebbe eccessivo definirlo scioccante, visto che a un certo punto c’è un notevole plot twist che porta a vedere ogni cosa con una prospettiva del tutto inedita. Negli scenari suggestivi della giungla malese si innescano così le dinamiche più ataviche della psiche umana: c’è chi ragiona nell’ottica del gruppo, chi agisce invece sospinto dall’egoismo, chi è arrogante e chi cerca il dialogo.
L’obiettivo è uno solo per tutti e non sono nemmeno previste eliminazioni. D’altro canto, in ogni puntata viene nominato dal gruppo un leader che deve guidare i partecipanti e prendere decisioni importanti. Alla fine, però, si fanno i conti, e Money Road offre spunti preziosissimi di riflessione su quella che è la nostra società e come le pulsioni individuali incidano sul benessere (o il malessere) della comunità in cui sono inseriti. Un gioco sì, ma fino a un certo punto.
The Traitors e Money Road: dalla dimensione dello show a quello del game

Dopo aver individuato gli elementi di forza dei singoli prodotti, parliamo brevemente delle affinità che condividono. Riassumibili in una frase: mentre in passato i reality scommettevano su dinamiche psicologiche collaterali che davano vita al racconto in modo spontaneo, in questi casi c’è una scrittura certosina delle regole che mettono le componenti psicologiche e sociologiche al centro, fino in fondo. Dallo show dell’esibizione si entra allora nella dimensione del gioco. Un gioco cinico sì, e per questo accattivante. Un gioco in cui regole, obiettivi e finalità sono dettate da una mano invisibile che coinvolge anche lo spettatore con un ruolo più attivo, e un coinvolgimento che va oltre l’empatia generata dai personaggi.
Sono affinità evidenti, anche se a guardarli in superficie sembrano due format lontanissimi.
Uno è un percorso fisico pieno di ostacoli e penalità economiche, l’altro un gioco sociale fatto di bluff, accuse e paranoie. Eppure condividono la stessa architettura narrativa: in entrambi i casi la competizione è solo una parte della questione, mentre la vera partita si gioca nella mente delle persone. Money Road e The Traitors funzionano così bene proprio perché mettono i concorrenti dentro un piccolo ecosistema chiuso, li costringono a dipendere l’uno dall’altro. Da lì, le dinamiche sociali implodono. La paura di essere inadeguati, il bisogno di essere accettati, il terrore di sbagliare e l’ansia del giudizio del gruppo: è tutto lì, in chi sbaglia una prova facendo perdere soldi a tutti o in chi abbassa lo sguardo per non essere accusato al tavolo delle eliminazioni.
Sono reality game in cui ruba la scena la fragilità dell’io sociale. Il modo in cui le persone reagiscono quando il loro status nel gruppo vacilla diventa parte dello spettacolo. È lì che emergono colpe, alleanze tossiche, autoinganni e piccole crudeltà quotidiane.
Money Road e The Traitors scavano nella stessa verità spiacevole. Ci mostrano come ci comportiamo davvero quando siamo messi sotto pressione e nessuno può salvarci dalla nostra stessa psiche.
Uno spaccato autentico, se osservato in sé e per sé: il nostro è uno sguardo che giudica, mentre i format sono amorali. Lasciano a noi ogni possibile prospettiva d’analisi. E noi, dal canto nostro, non siamo i voyeur di un tempo, non solo almeno: diventiamo parte del conflitto, riflettendo su come ci saremmo comportati al posto dei giocatori. La storia dei reality si è sempre sviluppata in queste direzioni, ma si sublima ora sotto forme in cui la psicologia e la sociologia ricoprono una centralità assoluta.
È per certi versi un ritorno alle origini. Anche il Grande Fratello italiano, d’altronde, era nato nell’ormai lontano 2000 con presupposti affini.
La psicologia c’è sempre stata, ma cambia il modo in cui la si mette a fuoco. Prima filtrata dal tempo lungo della convivenza, oggi scandita dalle regole serrate del gioco. I reality storici si affidavano però al caos naturale dei rapporti umani; i reality game moderni trasformano quel caos in una sequenza di scelte obbligate, dove ogni mossa rivela qualcosa di chi la compie. Con loro, pure di noi.
Le formule televisive di successo stanno andando in un’altra direzione. Con formati più snelli e veloci dall’identità di gioco più specifica, più proiettata sulla scrittura delle premesse e delle variabili. È un’evoluzione che risponde alle esigenze di un pubblico che vuole tensione immediata e payoff costanti: sono caratteristiche difficili da ottenere nei reality tradizionali. Caratteristiche ideali per target diversi, fondamentali per una televisione che si riscopre parente di quella di un tempo. Non è un cambio di identità del reality, ma un cambio di priorità: il racconto non è più guidato dalla spontaneità del gruppo, bensì dalla struttura del gioco. Un rinnovamento sì, non una rivoluzione: basta questo, però, per proporre qualcosa di davvero nuovo al grande pubblico.
Rispondono bene, soprattutto, alle logiche delle piattaforme: catturano subito, non richiedono un investimento narrativo lungo e generano facilmente discussione fuori dallo schermo.
Nell’era degli algoritmi e dei prodotti che spesso si replicano in forme simili, c’è ancora chi sa guardare al domani senza dimenticare le lezioni del passato. Li chiamano reality sì, ma sono i game le voci del presente. Voci innovative, e ben vengano: in fondo, è un atto di fiducia nei confronti del pubblico. Per tutti gli altri, non temete: le alternative non mancano mai.
Antonio Casu