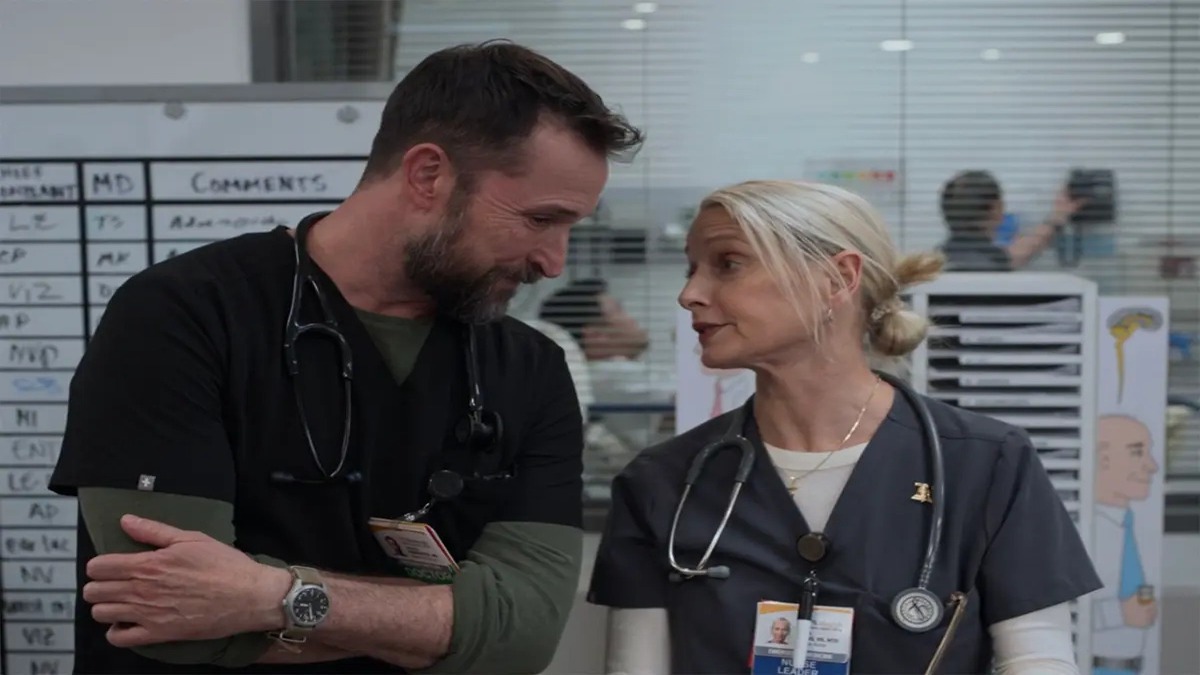ATTENZIONE: il seguente articolo potrebbe contenere spoiler su Synden.
Ogni giorno proviamo a raccontare le serie TV con la stessa cura e passione che ci hanno fatto nascere. Se sei qui, probabilmente condividi la stessa passione anche tu.
Se quello che facciamo è diventato parte delle tue giornate, allora DISCOVER è un modo per farci sentire il tuo supporto.
Con il tuo abbonamento ci aiuti a rimanere indipendenti e liberi di scegliere cosa raccontare, e in cambio:
✓ Accedi a oltre 700 articoli premium all'anno
✓ Ricevi consigli personalizzati su cosa vale la pena vedere
✓ Navighi senza pubblicità e su una sola pagina
Grazie: il tuo supporto fa davvero la differenza.
All’inizio del 2026, Netflix ci accoglie con Synden (titolo originale svedese di Land of Sin) una miniserie in cinque episodi scritta e diretta da Peter Grönlund, già noto per Beartown e Goliath. Ambientata nella penisola rurale di Bjäre, la serie si presenta con tutti gli ingredienti del classico nordic noir. Una detective tormentata, un adolescente morto in circostanze sospette, una comunità ostile, segreti familiari, traffico di droga e un paesaggio fangoso che sembra respirare dolore. Eppure, malgrado la maestria formale, Synden non riesce mai a sollevarsi oltre la sua impeccabile confezione. È una storia perfettamente adatta alla televisione ma priva di quella scintilla narrativa che trasforma un prodotto ben fatto in un’opera memorabile.
La trama: un mistero che promette ma non sconvolge

Synden ruota attorno alla morte di Silas Duncke, un adolescente ritrovato annegato con segni di violenza. A indagare è Dani Anttila (Krista Kosonen), una detective di Malmö che ha un legame personale con la vittima. Silas, infatti, era stato per un periodo suo figlio adottivo. Il caso la riporta a Bjäre, una comunità che non la vuole, dove il padre morente di Silas, Ivar, la implora di trovare la verità. Al suo fianco, il giovane collega Malik (Mohammed Nour Oklah), figura rispettosa delle regole che funge da contraltare alla sua impulsività. Ma il vero motore emotivo del racconto è il rapporto tra Dani e suo figlio biologico, Oliver, tossicodipendente, rancoroso, e forse coinvolto nella morte di Silas.
La trama di Synden si muove con il ritmo calibrato di un thriller seriale. Ogni episodio, infatti, aggiunge un tassello, introduce un nuovo sospetto, rivela un trauma familiare. Eppure, nonostante questa struttura solida, il mistero non riesce mai a generare vera tensione. Non perché sia prevedibile (anche se…) ma perché manca di una posta emotiva sufficientemente alta. Le domande che la serie pone, come per esempio chi ha ucciso Silas e che ruolo abbia avuto Oliver, vengono trattate come enigmi da risolvere, non come ferite da esplorare.
Personaggi: superfici ben disegnate ma senza profondità
Krista Kosonen interpreta Dani con una stanchezza viscerale, un dolore silenzioso che emerge nei silenzi più che nei dialoghi. È un’eroina tipica del genere: fragile, ribelle, tormentata dal senso di colpa. Ma la sceneggiatura le concede poco spazio per evolversi. Dani è perennemente in movimento ma non cambia mai davvero. Il suo conflitto con Oliver, potenzialmente il cuore della serie, viene accennato, mai approfondito. Vediamo i loro litigi, i loro sguardi carichi di odio ma soprattutto di rimpianto. Ma non entriamo mai nella complessità di una madre che ha fallito due figli in modi diversi, quello naturale e quello affidato, e che ora deve scegliere tra giustizia e protezione.
Il personaggio più riuscito è senza dubbio Elis (Peter Gantman), lo zio di Silas. Con il suo volto segnato, la voce monotona e una lealtà familiare fuori dalla legge, Elis incarna quel genere di ambiguità morale che rende grande il noir. È un patriarca che ama ma che sa anche uccidere. Eppure, anche lui resta incastrato in una funzione puramente narrativa. Antagonista prima, alleato poi ma mai esplorato nella sua interezza. Il suo passato, le sue contraddizioni, i suoi silenzi meritavano uno spazio che Synden non gli concede.
Quanto a Malik, il personaggio non riesce a emergere affatto. È tappezzeria, come si dice in gergo. Esiste per ricordare a Dani le regole, per guidare lo spettatore con domande ovvie, ma non ha un arco, una voce, una storia propria. La sceneggiatura ci prova quando tira fuori la famiglia, i suoi dubbi di padre ma resta tutto in superficie, all’acqua di rose. Ed è un vero peccato, perché in un’epoca che chiede rappresentazioni autentiche e complesse, Malik finisce per essere una presenza puramente decorativa.
Atmosfera e musica: dove Synden brilla davvero

Se c’è un aspetto in cui Synden si distingue è la colonna sonora. Non si tratta di una semplice accompagnamento d’atmosfera: la musica è parte integrante del racconto. Le melodie di piano, i rintocchi di banjo, i ritmi percussivi creano un’ansia sotterranea che accompagna ogni scena. La musica non illustra il dolore. Lo anticipa, lo amplifica e lo rende fisico. È forse l’unico elemento della serie che osa andare oltre la formula, che prova a dire qualcosa in più senza bisogno di parole.
Anche la fotografia contribuisce a costruire un mondo opprimente: inquadrature strette, luci soffuse, paesaggi autunnali dominati dal fango e dal grigio. Tuttavia, manca un senso di luogo forte, una identità chiara, precisa. Netta. Bjäre potrebbe essere qualunque periferia abbandonata, in Svezia come in Pennsylvania. Il titolo Synden, “Terra del Peccato“, evoca un’eredità morale legata a un suolo specifico ma la serie non riesce a trasformare quel pezzo di terra in un personaggio, come invece fa, con maestria, Mare of Easttown. Lì, ogni strada, ogni bar, ogni casa racconta una storia collettiva di lutto, povertà e resilienza. In Synden, i luoghi restano sfondi.
Famiglia e responsabilità: il tema centrale, trattato in modo superficiale
Il nucleo tematico di Synden è chiaro fin dall’inizio: la responsabilità genitoriale. Dani, Ivar, Elis, persino Oliver, tutti sono genitori, o figure genitoriali, che hanno fallito in modi diversi. La serie pone domande urgenti: cosa significa proteggere un figlio quando è lui stesso a essere la minaccia? Fino a che punto possiamo perdonare chi ha sbagliato per proteggerne un altro? Può esistere la redenzione senza verità?
Eppure, queste domande vengono poste ma non esplorate. I legami familiari sono evocati con efficacia visiva fatta di sguardi, silenzi, gesti ma mancano le scene che scavano, che rimescolano, che feriscono. Synden preferisce suggerire piuttosto che mostrare, accennare piuttosto che raccontare. Il risultato è un racconto emotivamente cauto, che teme di sconvolgere lo spettatore con troppa verità.
Un finale coerente ma accomodante
Il finale di Synden risulta perfettamente in linea con il tono e l’approccio narrativo dell’intera miniserie. Non sorprende, non devia, non scuote. Propone una forma di redenzione, la rottura dei cicli di violenza e il tentativo di ricucire legami familiari lacerati, ma lo fa con una delicatezza talmente controllata da apparire quasi consolatoria. Manca una vera catarsi, un momento di condivisione del dolore o di confronto diretto con le conseguenze più buie delle scelte dei personaggi. Ciò che resta è una chiusura composta, equilibrata, che riordina i pezzi senza mai scompigliarli davvero. In un genere come il noir, che trae forza dall’ambiguità morale, dalla disperazione esistenziale e dalle domande senza risposta, questa scelta risulta inevitabilmente cauta. E forse proprio per questo coerente: se la serie non ha mai voluto scavare fino all’osso, non poteva concludersi certo con una ferita aperta.
Synden nel panorama del noir contemporaneo

Se si volesse paragonare Synden a qualcosa di simile, l’unico riferimento plausibile, per ambientazione, struttura e temi, è Mare of Easttown. Ma il confronto è impietoso. Dove Mare of Easttown è una serie che scava nelle viscere di una comunità, che mostra il lutto come un male collettivo, che rende ogni personaggio una ferita aperta, Synden si accontenta di raccontare un caso di omicidio con contorno di trauma familiare. Non c’è la stessa crudezza, lo stesso coraggio emotivo, la stessa volontà di guardare il dolore negli occhi senza voltarsi.
Synden è, in sostanza, un prodotto perfettamente funzionale e per questo, paradossalmente, non necessario. È una miniserie che non tradisce ma nemmeno commuove. Che non delude ma non lascia traccia.
Una terra del peccato senza peccatori veri
Synden è una miniserie ben costruita, con una regia sicura, interpretazioni solide e una colonna sonora che merita l’attenzione. Ma è anche una serie che rinuncia a osare. Vive all’interno dei confini del genere, senza mai provare a superarli. I suoi personaggi sono ben disegnati ma non vivi. I suoi temi sono urgenti ma vengono trattati con cautela. Il suo titolo evoca un luogo maledetto ma quel luogo non riesce mai a diventare mito.
In un’epoca in cui lo streaming produce decine di thriller al mese, Synden non si distingue per originalità ma per competenza. E a volte, la competenza non basta. Perché il noir, soprattutto il noir di oggi, non chiede solo un buon mistero. Chiede un’anima. E Synden, per quanto ben vestita, ne è praticamente sprovvista.
Terra del peccato, sì ma di un peccato troppo educato per fare paura. La serie conosce le regole del gioco, ma non vuole rischiare di perderlo. Promette tenebra, eppure si ferma prima dell’oscurità vera. Parla di famiglia, di legami spezzati, di colpa e protezione ma non mostra mai il sangue che tiene insieme o lacera quelle relazioni. Resta in bilico sulla soglia, come chi bussa a una porta senza mai entrare. E forse è proprio lì, in quella sospensione, che si rivela il suo limite più profondo. Non il fallimento ma la scelta di non andare fino in fondo.