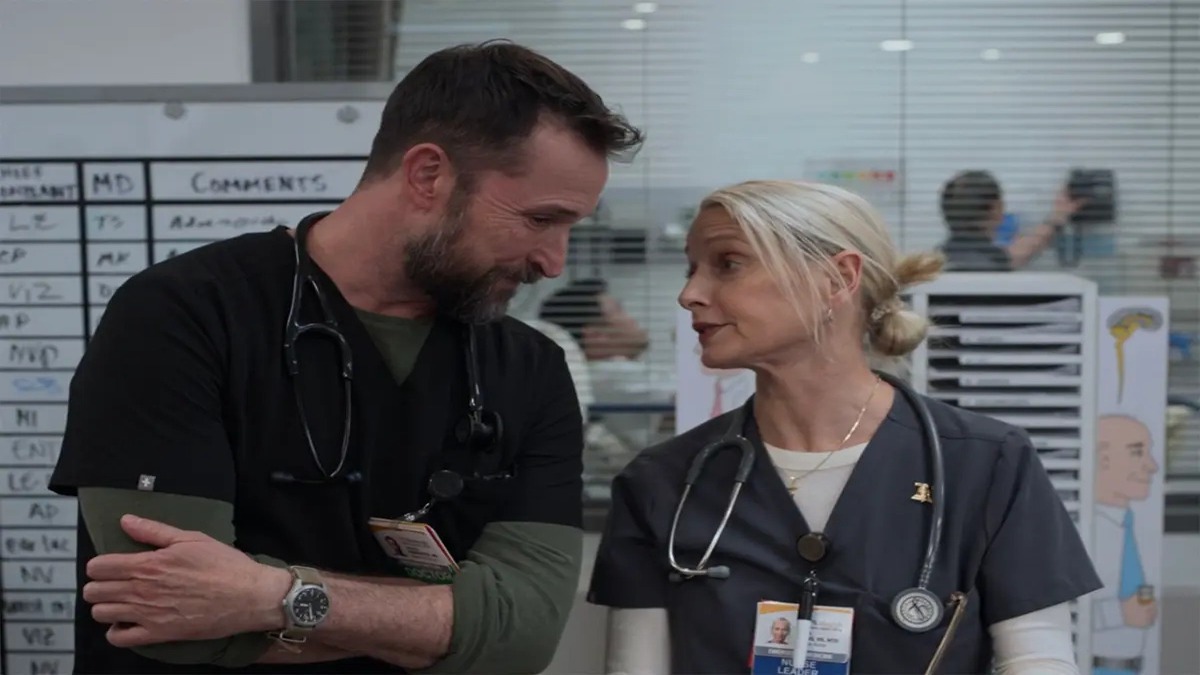Ogni giorno proviamo a raccontare le serie TV con la stessa cura e passione che ci hanno fatto nascere. Se sei qui, probabilmente condividi la stessa passione anche tu.
Se quello che facciamo è diventato parte delle tue giornate, allora DISCOVER è un modo per farci sentire il tuo supporto.
Con il tuo abbonamento ci aiuti a rimanere indipendenti e liberi di scegliere cosa raccontare, e in cambio:
✓ Accedi a oltre 700 articoli premium all'anno
✓ Ricevi consigli personalizzati su cosa vale la pena vedere
✓ Navighi senza pubblicità e su una sola pagina
Grazie: il tuo supporto fa davvero la differenza.
ATTENZIONE: proseguendo nella lettura potreste incappare in spoiler su Boots.
Nel panorama delle serie che raccontano la formazione in ambienti militari, Boots rappresenta un tentativo coraggioso, e rischioso, di fondere il coming-of-age queer con la rigidità repressiva del genere militare.
La nuova dramedy di Netflix creata da Andy Parker, prodotta postuma dal gigante Norman Lear (I Jefferson e Pomodori verdi fritti alla fermata del treno, tra le altre cose) e tratta dal memoir The Pink Marine di Greg Cope White, è uscita lo scorso giovedì 9 ottobre 2025.
Ambientata nel 1990, alla vigilia della famigerata politica Don’t Ask, Don’t Tell, la serie segue le vicende del giovane Cameron Cope (Miles Heizer), recluta gay che si arruola nei Marines insieme all’amico Ray (Liam Oh), in fuga da una madre caotica (Vera Farmiga, che torna in tv dopo Cinque giorni al Memoral) e da anni di bullismo. Ma il cuore pulsante di Boots sta tutto in un paio di domande scomode. Cosa siamo disposti a perdere pur di sopravvivere? E ancora, cosa ci rimane davvero quando abbiamo imparato a mimetizzarci?
La trama: una formazione tra desiderio e annientamento

Boots si apre con Cameron, un adolescente fragile e introverso, che cerca un nuovo inizio iscrivendosi alla selezione dei Marines assieme all’amico Ray. La sua scelta non è dettata da patriottismo o vocazione ma da un bisogno disperato di fuga. Dal bullismo scolastico che lo ha ridotto a un bersaglio silenzioso. Dall’instabilità emotiva di una madre disattenta che lo saluta con un “prendi il latte scremato“. E da un’adolescenza segnata dall’invisibilità. Quel passo verso l’uniforme è, per lui, un atto di speranza. L’illusione che in un posto dove tutti sono uguali, forse anche lui potrà finalmente sentirsi normale.
Ma da subito, la serie mostra la distanza abissale tra questa aspettativa e la realtà brutale del campo di addestramento a Parris Island. Appena sceso dall’autobus, Cameron viene travolto da un turbine di urla, insulti e umiliazioni rituali. I sergenti istruttori non insegnano a combattere, insegnano a obbedire. Non formano individui, li spogliano fino a ridurli a un numero, un corpo, una voce all’unisono. Il sistema non tollera eccezioni. Chi è troppo lento, troppo grasso, troppo diverso (e, soprattutto, chi nasconde qualcosa) viene messo alla prova non solo fisicamente, ma esistenzialmente.
La struttura della serie segue con precisione quasi documentaria le tredici settimane dell’addestramento di base
Dalle corse infinite e i percorsi a ostacoli, al tiro al bersaglio, fino alla prova finale che sancisce il passaggio da recluta a Marine. In questo percorso, ogni settimana diventa un capitolo di una metamorfosi forzata, in cui le vessazioni si intrecciano con momenti di cameratismo inaspettato, le crisi individuali si dissolvono nel coro del plotone, e le piccole speranze assumono il peso di autentiche vittorie.
Ma mentre il corpo di Cameron si irrobustisce la sua anima si assottiglia. La voce interiore, quella versione libera, ironica, appassionata di Wilson Phillips e Cuori senza età, che all’inizio lo incoraggia con sarcasmo affettuoso, col passare delle settimane parla sempre meno, fino a scomparire quasi del tutto. Quella ricerca iniziale di appartenenza si trasforma così in una battaglia silenziosa per la sopravvivenza dell’identità personale. Non per affermarsi, ma per non dissolversi del tutto. E in questo, Boots racconta non tanto la nascita di un soldato, quanto la lenta, dolorosa scomparsa di un ragazzo che impara a sopravvivere solo smettendo di brillare.
Cameron Cope: il paradosso del protagonista
Cameron è scritto e interpretato come un eroe che non si ribella ma si dissolve. La sua anima tormentata si sdoppia in due voci. Quella esteriore, impaurita e sottomessa, che obbedisce agli ordini, abbassa lo sguardo e impara a camminare in punta di piedi tra insulti e sguardi sospetti. E quella interiore, ironica appassionata, che commenta con sarcasmo affettuoso le assurdità del campo di addestramento. Questa voce off, più sicura e libera, funge da contrappunto alle azioni di Cameron, sottolineando con precisione chirurgica il tema della dissociazione e della fatica costante del dover nascondersi non solo alla comunità, ma anche a se stessi.
Questa scelta narrativa merita una menzione speciale perché intercetta una delle verità meno raccontate nei percorsi queer di formazione: non tutte le storie passano per il coraggio e la ribellione. Molte, più realisticamente, attraversano il silenzio, la paura, la mimetizzazione. Boots, anche quando racconta scene tragiche o commoventi (come la morte improvvisa di una recluta o il confronto con l’omofobia strisciante dei compagni) si tiene sempre distante dal melodramma abbracciando una quotidianità fatta di compromessi e, soprattutto, di perdite silenziose. Cameron non diventa un eroe, diventa un sopravvissuto. E in un contesto in cui essere scoperti equivaleva a espulsione, umiliazione, forse persino arresto, la sopravvivenza diventa un atto politico, anche se invisibile.
Sullivan: la tragedia dell’identità repressa

Il personaggio del sergente Sullivan (un sorprendente Max Parker) emerge come l’anima oscura della serie. Dapprima antagonista spietato, con una fisicità imponente e un’autorità quasi mitologica, man mano si svela come specchio oscuro del protagonista. La sua parabola tragica incarna ciò che Cameron potrebbe diventare, cedendo completamente alla logica della sopravvivenza e della negazione. E aggiunge profondità e disincanto al ritratto corale della serie. Sullivan non è un cattivo. È un uomo spezzato che ha trasformato il proprio dolore in disciplina, la propria vergogna in rigore, la propria solitudine in autorità. La sua ossessione per Cameron non è solo sadismo: è riconoscimento. Vede in lui ciò che era, e forse teme ciò che potrebbe diventare.
La sua presenza porta Boots su territori dove la commedia lascia il passo al dramma puro, anche se la serie, pur intravedendo la tragedia, sceglie di non affondare mai il colpo in modo davvero spietato. La morte in caserma è agghiacciante e il destino di Sullivan sfiora la catastrofe esistenziale ma la serie si ferma sempre un passo prima del baratro. Questo non è un difetto, ma una scelta coerente: non vuole traumatizzare, ma testimoniare. Eppure, proprio nella figura di Sullivan risiede la critica più aspra al sistema. Non è l’omofobia esterna a distruggere, ma la necessità di interiorizzarla, di farla diventare parte del proprio codice morale. Sullivan è il Marine perfetto ma anche l’uomo annientato. E in questo paradosso sta tutta la forza tragica della serie.
Un racconto corale, tra affresco sociale e rischio dispersione
Attorno a Cameron e Sullivan si muove un cast secondario ricco e vario. La serie costruisce un affresco corale fatto di traumi, fughe da famiglie disfunzionali e fame di riconoscimento sociale. Un microcosmo dell’America marginale che, negli anni ’90, vedeva il servizio militare volontario come l’unica via d’uscita da povertà, abbandono e invisibilità.
Tuttavia, questa coralità rischia di annacquare il nucleo narrativo principale. Cameron, che dovrebbe essere il centro emotivo, viene spesso eclissato dalle storie dei comprimari e dagli intrecci paralleli. L’alternanza tra focus individuale e affresco sociale, pur ambiziosa, talvolta lascia insoddisfatti sotto entrambi i punti di vista, dando l’impressione di una narrazione che tocca tutto, senza mai scavare davvero a fondo nei temi più brucianti. I flashback sui gemelli, per esempio, sono efficaci ma interrotti bruscamente dalla loro separazione. Il Capitano Fajardo (Ana Ayora), prima donna a guidare una compagnia maschile, introduce con forza il tema della misoginia, ma il suo arco resta marginale. Il risultato è un’opera affollata, generosa, ma dispersiva. Un po’ come il campo di addestramento stesso, dove ogni voce cerca di farsi sentire, ma solo poche riescono a emergere.
Boots: tra delicatezza e rischio di edulcorazione
Uno degli aspetti più interessanti e controversi al tempo stesso di Boots sta proprio nell’equilibrio tra leggerezza e profondità. Rispetto ai modelli di riferimento del genere (basti pensare alla crudezza di Full Metal Jacket, omaggiato più volte), qui ogni scena di violenza od ostracismo viene smorzata da una regia delicata e da un tono complessivo che preferisce suggerire piuttosto che mostrare. Gli istruttori urlano, certo, ma sono anche figure spesso motivate da un senso di responsabilità quasi paterno. Persino nei momenti più duri la serie mantiene un distacco che pare quasi rispettoso del contesto più che dei suoi drammi.
Questo registro, probabilmente una scelta anche dettata dall’eredità di Norman Lear e dal desiderio di parlare a un pubblico trasversale, produce da un lato un racconto accogliente, mai moralista, che abbraccia l’umanità imperfetta dei suoi personaggi. Dall’altro rischia una eccessiva addomesticazione delle tensioni e delle sofferenze reali affrontate da giovani queer nell’esercito americano degli anni Novanta. Ciò che nella realtà era illegale e pericoloso qui diventa un’ombra più che una presenza attiva.
Non c’è una scena in cui Cameron teme veramente per la sua vita. Nemmeno un momento in cui il sistema lo minaccia esplicitamente. E questa prudenza, pur comprensibile, toglie spessore storico alla narrazione, trasformando una realtà brutale in una metafora educata.
Boots e l’ambiguità dell’istituzione militare

Laddove altri prodotti hanno scelto di scardinare il mito del marine perfetto, Boots preferisce mantenere una prospettiva da testimone filtrando l’esperienza personale e relegando la critica politica a pochi accenni, spesso affidati a dialoghi marginali o a spunti non sviluppati a fondo. Questo approccio lascia spazio a una domanda implicita: la sopravvivenza passa dall’adesione o dal rifiuto del sistema? La serie evita di dare risposte nette e preferisce restare in bilico tra gratitudine (per il senso di appartenenza trovato), malinconia (per ciò che è stato perso) e rimpianto (per ciò che non si è potuto essere). E in questo equilibrio instabile risiede sia la sua forza che il suo limite.
L’identità queer e il prezzo dell’invisibilità
L’impianto narrativo di Boots lavora con grande attenzione sul tema dell’identità queer in ambienti ostili, scegliendo però di rappresentare il coming-of-age più come processo di adattamento che come ascesa trionfale. Se molte storie contemporanee privilegiano il racconto della visibilità, del coraggio, della conquista sociale, Boots propone una verità minoritaria e scomoda: a volte sopravvivere significa smettere di brillare, nascondersi, dissolversi per non rischiare di essere eliminati. Cameron, in questo senso, è il personaggio queer non eroe, che sopravvive perché non osa (o non può permettersi di) sfidare il sistema apertamente. Non fa coming out, non si innamora in modo esplicito, non combatte per i propri diritti. Eppure, la sua presenza è rivoluzionaria perché dimostra che anche chi tace ha diritto a una storia.
Questa scelta, per quanto dolorosa e criticabile, rappresenta una verità umana e storica che troppo spesso la fiction finisce per rimuovere in favore di narrazioni più rassicuranti. Il percorso di Sullivan funge da monito: chi cede troppo al sistema rischia la devastazione interiore. Accanto a questa linea principale, la serie tratteggia altri temi solo abbozzati (razzismo, grassofobia, misoginia) lasciando agli spettatori il compito di riflettere su cosa comporta in ultima analisi l’omologazione.
Scrittura, tono e interpretazioni

Boots può contare su una scrittura sensibile, attenta a evitare tanto i toni retorici quanto quelli scandalistici. E su un cast che regala ottime prove. Vera Farmiga crea una madre nevrotica e vulnerabile, capace di ridurre un addio storico a una richiesta di latte scremato. Max Parker firma una delle interpretazioni ricca di sfumature trasformando Sullivan in un’icona tragica della repressione. I giovani comprimari aggiungono credibilità e varietà al racconto. Notevoli sono anche i momenti di ironia pop, affidati alle passioni musicali di Cameron (George Michael, Sade, i Queen) o alle citazioni dissacranti della cultura queer che alleggeriscono il tono senza mai cadere nel macchiettismo.
Non mancano, tuttavia, limiti evidenti: la scelta di mantenere il tutto su un registro prudente toglie spessore ai conflitti e ai traumi, mentre la ricchezza dei personaggi secondari diluisce la centralità narrativa. C’è anche una certa stereotipia nei comprimari e una superficialità nel trattare temi di fondo come la manipolazione emotiva o la violenza sistemica. La sensazione finale è quindi quella di una storia ordinata, spesso suggestiva, ma che raramente riesce a schiodarsi dalla comfort zone della narrazione beneducata. È una serie che emoziona, ma raramente ferisce; che illumina, ma non incendia.
Boots: uno specchio più che un modello
Boots non è né un manifesto né un atto d’accusa. È un racconto onesto, disilluso ma non disperato, che sa parlare tanto ai giovani quanto a chi abbia vissuto sulla propria pelle il desiderio di appartenenza e di accettazione. Con tutti i suoi difetti la serie resta un’opera necessaria nel nostro panorama. Non tanto come esempio da seguire ma come domanda aperta sul costo umano della sopravvivenza e sulle strategie minime per restare se stessi in un mondo che invoca, ancora oggi, l’omologazione come garanzia di pace e sicurezza.
In una stagione televisiva spesso segnata da titoli autoreferenziali e già visti, Boots emerge come una boccata d’aria che rifiuta il trionfalismo facile e sceglie la via difficile dell’empatia e del dubbio. Non riscrive i paradigmi né spinge davvero fino al fondo delle proprie premesse ma illumina con tatto un angolo di storia che merita ascolto. Quello di chi cerca il proprio posto nel mondo, anche a costo di doverlo inventare ogni giorno da capo. Magari in uniforme, con la testa rasata, e il cuore nascosto sotto il giubbotto antiproiettile dell’adattamento.